 «La disinvoltura con cui molte critiche sfociano nell’insulto è vizio piuttosto diffuso, che desta ancor più preoccupazione se praticato da gente di scuola, da cui sarebbe legittimo attendersi un contributo a mantenere ogni discussione su toni di confronto civile, o anche solo di buona educazione».
«La disinvoltura con cui molte critiche sfociano nell’insulto è vizio piuttosto diffuso, che desta ancor più preoccupazione se praticato da gente di scuola, da cui sarebbe legittimo attendersi un contributo a mantenere ogni discussione su toni di confronto civile, o anche solo di buona educazione».
Queste le parole sacrosante scritte da Ivana Barbacci, segretaria della Cisl Scuola. Peccato che la stessa Barbacci, poche righe prima, abbia apostrofato come «demente» chi su Facebook l’ha accusata di essere una “venduta” per avere firmato il rinnovo contrattuale 2022-24 del settore scuola che certifica un aumento dello stipendio del 6% a fronte di un’inflazione sul triennio del 17%.
Da insegnante mi desta molta preoccupazione questo atteggiamento della segretaria della Cisl Scuola. Sembra una di quelle maestre che implicitamente trasmettono il messaggio: «Fate quel che dico, ma non fate quel che faccio».
Certo, sentirsi dare della venduta deve essere molto fastidioso, ma se sei a capo di un’importante organizzazione sociale devi avere la scorza per non farti scalfire dalle forti critiche; e invece Barbacci risponde a una critica con un insulto, visto che «demente» – come spiega il vocabolario Treccani – è usato anche «come titolo d’ingiuria».
Di insulto Barbacci ne ha usato pure un altro («imbecilli»), ma almeno qui ha avuto la furbizia di schermarsi rievocando parole di Umberto Eco (la cui statura intellettuale lo legittimava all’uso di un termine non proprio elegante).
Continua a leggere


 Salvador Allende nel palazzo de La Moneda durante il bombardamento
Salvador Allende nel palazzo de La Moneda durante il bombardamento Anna Danesi, 29 anni, capitana della nazionale italiana di pallavolo, è riuscita a parlare in modo così profondo – in un’
Anna Danesi, 29 anni, capitana della nazionale italiana di pallavolo, è riuscita a parlare in modo così profondo – in un’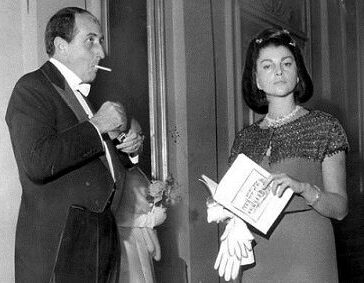
 Per il 2025 il governo ha elargito
Per il 2025 il governo ha elargito 


 fondamenta della società contemporanea – rappresenta la situazione politico-culturale dell’Italia.
fondamenta della società contemporanea – rappresenta la situazione politico-culturale dell’Italia. 


 In una lettera pubblicata da La Tecnica della Scuola, c’è chi ha scritto – sospinto da imprecisione e luoghi comuni – di «assenza di meritocrazia» tra gli insegnanti, «trattamento tendenzialmente egualitario degli studenti» nella valutazione, «scarsa disciplina impartita».
In una lettera pubblicata da La Tecnica della Scuola, c’è chi ha scritto – sospinto da imprecisione e luoghi comuni – di «assenza di meritocrazia» tra gli insegnanti, «trattamento tendenzialmente egualitario degli studenti» nella valutazione, «scarsa disciplina impartita». Nel mese di dicembre gli insegnanti, a vedere l’importo della tredicesima aggiunto allo stipendio consueto, pensano che se, non diciamo proprio tutta quella somma, ma diciamo a sfiorarla, essa fosse la normale mensilità, beh allora qualche grosso problema della scuola si inizierebbe a risolvere: uno stipendio corrispondente al ruolo sociale svolto dagli insegnanti obbligherebbe il sistema ad una seria selezione dei docenti, perché la professione diventerebbe ambita e tra tanti candidati emergerebbero da severi esami e colloqui solo i più preparati dal punto di vista pedagogico, didattico e personale (cioè: puoi essere il più preparato nei contenuti e nel metodo, ma se non sorridi manco all’apparizione di un arcobaleno, o se soffri di qualche disturbo psico-patologico, è meglio non lavorare con bambini e ragazzi!) .
Nel mese di dicembre gli insegnanti, a vedere l’importo della tredicesima aggiunto allo stipendio consueto, pensano che se, non diciamo proprio tutta quella somma, ma diciamo a sfiorarla, essa fosse la normale mensilità, beh allora qualche grosso problema della scuola si inizierebbe a risolvere: uno stipendio corrispondente al ruolo sociale svolto dagli insegnanti obbligherebbe il sistema ad una seria selezione dei docenti, perché la professione diventerebbe ambita e tra tanti candidati emergerebbero da severi esami e colloqui solo i più preparati dal punto di vista pedagogico, didattico e personale (cioè: puoi essere il più preparato nei contenuti e nel metodo, ma se non sorridi manco all’apparizione di un arcobaleno, o se soffri di qualche disturbo psico-patologico, è meglio non lavorare con bambini e ragazzi!) .


 «Un fastidio che non sapeva bene neanche lui. Erano le case: tutti questi nuovi fabbricati che tiravano su […] facevano a chi monta sulle spalle dell’altro». Da anni, quando vado in Liguria, sul treno e in acqua mi chiedo quale beatitudine agli occhi fosse un tempo la costa, e mi addoloro, stupido, per il paesaggio perduto; mi appare Capo di Noli di Signac, e immagino il viaggio in barca del pittore dalla Costa azzurra, i suoi sguardi che non possono più essere i nostri. E poi ho letto per caso: il sanremese Calvino, in treno per il ponente ligure, non riconosceva più la sua terra. Così all’apparizione del pittore in mare mi s’è aggiunto lo scrittore sul vagone, e mi sento meno stupido, e comparo la mia malinconia al dolore di chi, in quella riviera, vi crebbe. Calvino lo affrontò – insieme al «fastidio» – con
«Un fastidio che non sapeva bene neanche lui. Erano le case: tutti questi nuovi fabbricati che tiravano su […] facevano a chi monta sulle spalle dell’altro». Da anni, quando vado in Liguria, sul treno e in acqua mi chiedo quale beatitudine agli occhi fosse un tempo la costa, e mi addoloro, stupido, per il paesaggio perduto; mi appare Capo di Noli di Signac, e immagino il viaggio in barca del pittore dalla Costa azzurra, i suoi sguardi che non possono più essere i nostri. E poi ho letto per caso: il sanremese Calvino, in treno per il ponente ligure, non riconosceva più la sua terra. Così all’apparizione del pittore in mare mi s’è aggiunto lo scrittore sul vagone, e mi sento meno stupido, e comparo la mia malinconia al dolore di chi, in quella riviera, vi crebbe. Calvino lo affrontò – insieme al «fastidio» – con 

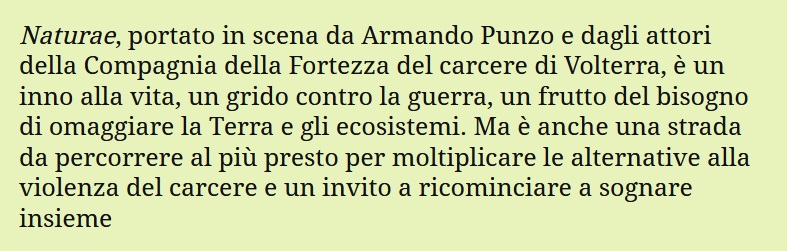
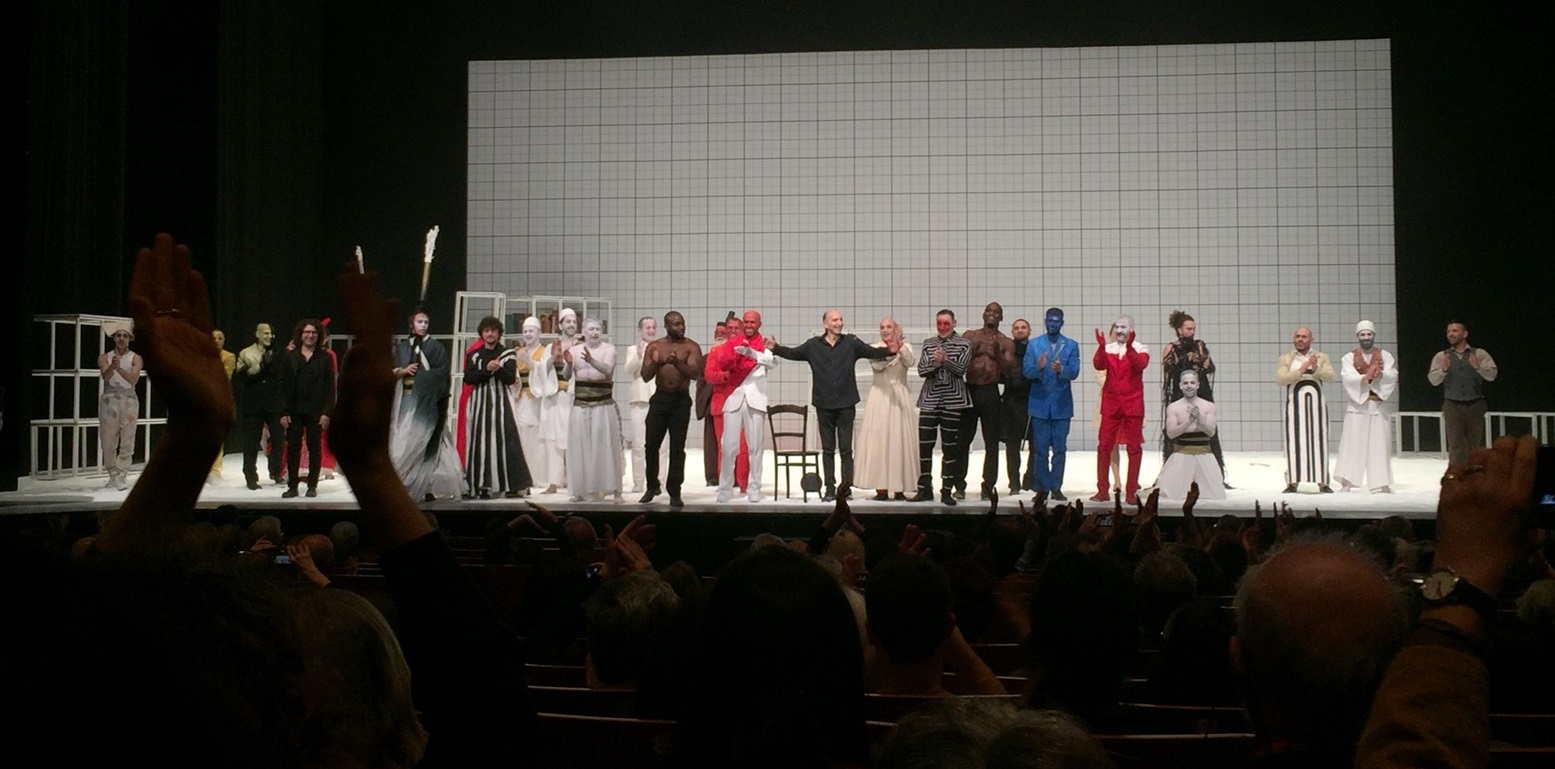


 letteratura e insieme la democrazia. Dovete preparare i giovani a leggere e a commentare un testo letterario; e ciò comporta anzitutto studiarlo oggettivamente nella sua autonomia rispetto al lettore, considerarlo nelle sue componenti storicoculturali e letterarie, linguistiche e stilistiche; ma poi dovete anche sollecitarne l’interpretazione, che comporta invece la partecipazione del lettore, chiamato a esprimere il significato per noi di un testo. Non solo e non tanto il significato per me, ma potenzialmente un significato per la intera comunità dei lettori.
letteratura e insieme la democrazia. Dovete preparare i giovani a leggere e a commentare un testo letterario; e ciò comporta anzitutto studiarlo oggettivamente nella sua autonomia rispetto al lettore, considerarlo nelle sue componenti storicoculturali e letterarie, linguistiche e stilistiche; ma poi dovete anche sollecitarne l’interpretazione, che comporta invece la partecipazione del lettore, chiamato a esprimere il significato per noi di un testo. Non solo e non tanto il significato per me, ma potenzialmente un significato per la intera comunità dei lettori. Foto tratta da Fb:
Foto tratta da Fb: 
 “Sueños al cielo” (detalle, fotograf
“Sueños al cielo” (detalle, fotograf



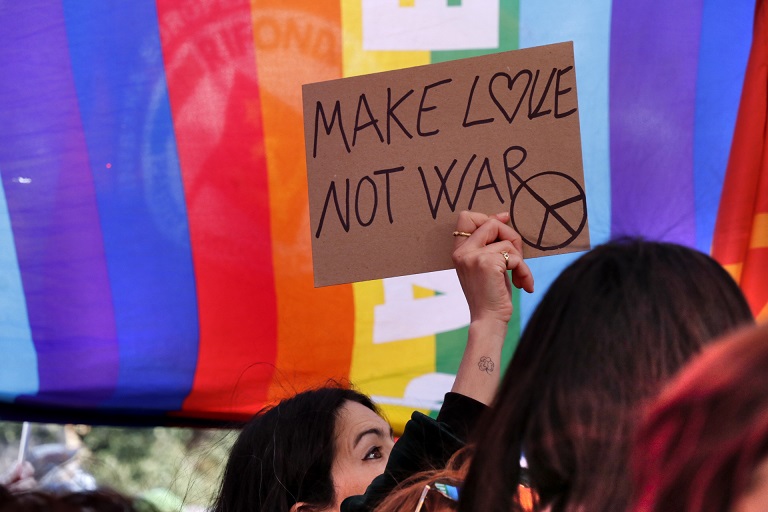
 Lezione fondamentale numero uno (per tutti gli adulti): non pensare che i bambini siano degli incompetenti. Come siamo immersi noi in un mondo di fatti, emozioni e notizie, lo sono anche loro: ascoltano e vedono ciò che accade intorno a loro, ragionano e – se ne viene data loro la possibilità – si esprimono. Hanno idee. E se li ascoltassimo, riusciremmo a cambiare il mondo.
Lezione fondamentale numero uno (per tutti gli adulti): non pensare che i bambini siano degli incompetenti. Come siamo immersi noi in un mondo di fatti, emozioni e notizie, lo sono anche loro: ascoltano e vedono ciò che accade intorno a loro, ragionano e – se ne viene data loro la possibilità – si esprimono. Hanno idee. E se li ascoltassimo, riusciremmo a cambiare il mondo.


 libri è deleterio, forse letale, per la nostra specie». Quante volte lo penso, da maestro elementare. Quanto è importante che lo dicano persone influenti come Strada.
libri è deleterio, forse letale, per la nostra specie». Quante volte lo penso, da maestro elementare. Quanto è importante che lo dicano persone influenti come Strada.





 sua attività giornalistica ha reso l’Italia migliore, nonostante avesse soltanto 26 anni quando venne trucidato dai colpi.
sua attività giornalistica ha reso l’Italia migliore, nonostante avesse soltanto 26 anni quando venne trucidato dai colpi. .
. e indifferenti alla cronaca – Samuele si riferiva al muro statunitense al confine con il Messico – ancora me la ritrovo ogni tanto a gironzolare per la testa, insieme a un’altra questione: e se si dessero bei voti anche per le domande degli studenti, invece che per le sole risposte?
e indifferenti alla cronaca – Samuele si riferiva al muro statunitense al confine con il Messico – ancora me la ritrovo ogni tanto a gironzolare per la testa, insieme a un’altra questione: e se si dessero bei voti anche per le domande degli studenti, invece che per le sole risposte?

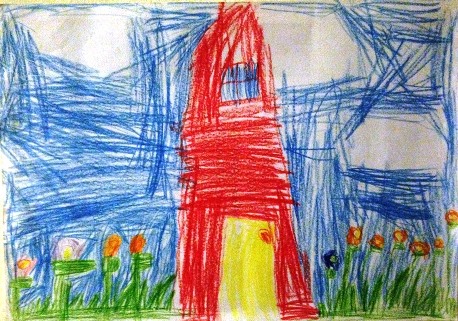
 un’emozione – un fuggevole calore meravigliato nell’animo – che credo di non avere mai prima conosciuto: dopo le prime tre settimane di lavoro a dicembre, chiamato in corso d’opera dalla scuola come maestro di sostegno, al rientro avevo quasi dimenticato che Sanaa cerca il contatto di noi insegnanti.
un’emozione – un fuggevole calore meravigliato nell’animo – che credo di non avere mai prima conosciuto: dopo le prime tre settimane di lavoro a dicembre, chiamato in corso d’opera dalla scuola come maestro di sostegno, al rientro avevo quasi dimenticato che Sanaa cerca il contatto di noi insegnanti.

 16 gennaio 1969 lo studente Jan Palach si cosparse di benzina e si diede fuoco in piazza San Venceslao a Praga, per protestare contro l’occupazione sovietica e chiedere idealmente la libertà di tutti i popoli: morì tre giorni dopo, il 19 gennaio. Aveva 21 anni.
16 gennaio 1969 lo studente Jan Palach si cosparse di benzina e si diede fuoco in piazza San Venceslao a Praga, per protestare contro l’occupazione sovietica e chiedere idealmente la libertà di tutti i popoli: morì tre giorni dopo, il 19 gennaio. Aveva 21 anni. Quand’ero fiore di futuro
Quand’ero fiore di futuro  dalle persone che ho incontrato là, intorno ai villaggi di Bandh e Patta nelle prime alture himalayane dello Stato nordico dell’Himachal Pradesh; è occupata dalle immagini di meraviglia cristallizzate come fotografie nella mente, e dai bambini con i quali ho lavorato nelle scuole, dai profondi disagi riscontrati e percepiti, dalle opportunità colte o dormienti, dagli insegnamenti tratti da un’esperienza che mi accompagnerà per il resto del mio cammino.
dalle persone che ho incontrato là, intorno ai villaggi di Bandh e Patta nelle prime alture himalayane dello Stato nordico dell’Himachal Pradesh; è occupata dalle immagini di meraviglia cristallizzate come fotografie nella mente, e dai bambini con i quali ho lavorato nelle scuole, dai profondi disagi riscontrati e percepiti, dalle opportunità colte o dormienti, dagli insegnamenti tratti da un’esperienza che mi accompagnerà per il resto del mio cammino.